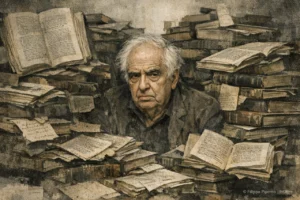In qualsiasi società che abbia raggiunto un minimo di complessità gli individui hanno identità sociali multiple, ma proprio per questo devono possedere una sorta di baricentro che gli consenta di coordinarle sia con le loro emozioni sia con la loro razionalità. Poiché le identità sociali evolvono col tempo, anche ogni specifico baricentro dovrà adeguarsi a tali cambiamenti, cercando di fare in modo che l’identità personale possa risultare sovrapponibile a quella del gruppo o dei gruppi di riferimento; e se ogni gruppo di riferimento è, dal punto di vista psicologico, una “collettività” con cui l’individuo condivide interessi e convinzioni, in ogni identità di gruppo c’è sempre anche, più o meno esplicitamente, una presa di distanza da altri gruppi.
Nel suo ultimo saggio (Identità e istituzioni. L’individuo, il gruppo, la politica, Il Mulino, Bologna 2025), Angelo Panebianco affronta in modo chiaro, esauriente e per molti versi illuminante i rapporti che sussistono tra le identità personali e di gruppo, sostenendo che “le identità, sia personali sia sociali, risultano strettamente connesse al modo in cui classifichiamo/categorizziamo il mondo esterno a noi stessi”. Raramente, tuttavia, “la dimensione ‘collettiva’ è in grado di mangiarsi interamente la dimensione personale o individuale”, sebbene questo fenomeno possa verificarsi in alcuni casi in modo più evidente che in altri.
Se lo psicologo sociale britannico Henri Tajfel, riprendendo una tesi di Friedrich Von Hayek, aveva sostenuto che le nostre azioni sono guidate da regole di cui spesso ignoriamo l’esistenza, ma che in qualche modo troviamo appropriate per orientarci e prendere decisioni in una certa situazione, pur partendo da questa premessa generale Panebianco distingue però, per evitare confusioni, l’identità sociale da quella di gruppo: “una persona può disporre di una pluralità di identità sociali collegate ai suoi diversi ruoli (ad esempio, coniuge, genitore, lavoratore, ecc.) senza che ciò comporti necessariamente l’identificazione in un gruppo. È solo in quest’ultimo caso che entrano in gioco identità collettive o di gruppo”.
I gruppi con cui ci si identifica possono essere formali o informali: se i primi hanno chiari confini organizzativi e una gerarchia interna che prevede una differenziazione dei ruoli, i gruppi informali possono tranquillamente farne a meno. I gruppi possono avere poi dimensioni diverse, e Georg Simmel aveva già spiegato, all’inizio del secolo scorso, che quelli grandi possono essere tenuti insieme solo da idee molto semplici, mentre i più piccoli possono condividere anche idee e opinioni più articolate. Ma quali sono i sentimenti o gli stati d’animo che più di altri servono a tenerli uniti e coesi?
Prima di rispondere a questa domanda, poiché l’esistenza dei gruppi caratterizza naturalmente anche la vita politica, con tutte le emozioni e gli scambi d’idee che la contraddistinguono, bisogna mettere intanto nella giusta evidenza la distinzione fondamentale tra governanti e governati, che possono essere considerati come due macrogruppi dotati di una identità approssimativa e piuttosto fluida. Ora, secondo una tesi riconducibile a Guglielmo Ferrero – uno storico, un sociologo e uno scrittore italiano che fu allievo di Cesare Lombroso e che oggi è ingiustamente poco conosciuto – il sentimento che regola più di ogni altro i rapporti tra governanti e governati è quello della paura, che può tuttavia variare a seconda delle circostanze: secondo Ferrero, infatti, la paura reciproca di governanti e governati è tanto minore quanto più il regime politico è avvertito come legittimo.
Già Thomas Hobbes aveva attribuito alla paura un funzione cruciale nelle definizione dei rapporti tra lo Stato e i cittadini, ma si tratta a ben vedere, come rileva anche Simmel, di rapporti caratterizzati da una sostanziale ambiguità: i governati, per esempio, possono essere preda di desideri contraddittori, e desiderare da un lato la protezione dei governanti, ma al tempo stesso percepirli come oppressori, e solo in certi regimi politici si raggiunge una sorta di equilibrio tra queste due tendenze.
Un’altra distinzione importante concerne invece i diversi tipi di “arena politica”. Sulla scia del politologo statunitense Harold Lasswell e del filosofo ucraino/americano Abraham Kaplan, Panebianco ne distingue due: le “arene civili” e le “arene militari”. Nelle prime, e cioè in primo luogo nelle democrazie, vi sono poteri indipendenti in grado di condizionare o arginare l’azione di governo e c’è una bassa aspettativa di violenza, mentre nelle seconde, quelle militari, tra cui spiccano quelle che Panebianco definisce “autocrazie stabilizzate”, esiste un dittatore in genere appoggiato da una coalizione dominante relativamente coesa che fa capo a lui. Queste “arene militari, al contrario di quelle civili, sono caratterizzate da un’alta aspettativa di violenza e da un pluralismo decisamente limitato, tanto che in taluni casi arrivano a coincidere con veri e propri sistemi totalitari.
A cavallo di questi due tipi di arene c’è però secondo Panebianco “un’ampia varietà di regimi autoritari”: le autocrazie rivoluzionarie, guidate da leader trasformativi, dove si ricorre sistematicamente a forme brutali di repressione; le dittature etniche, in cui una minoranza etnica o religiosa opprime una pluralità di minoranze etniche o religiose; e i regimi pretoriani, o militari, dove sono attive opposte fazioni che fanno abitualmente ricorso alla violenza politica per combattersi a vicenda. In genere, in tutte e tre queste situazioni l’opinione pubblica è decisamente radicalizzata e/o polarizzata in credenze politiche piuttosto semplici, capaci di suscitare un elevato coinvolgimento emotivo.
Nelle arene civili, e soprattutto nelle consolidate democrazie occidentali, l’opinione pubblica, sebbene non disponga di un coerente sistema di credenze politiche, non è tuttavia un aggregato amorfo. Essa è in genere composta da una maggioranza disorganizzata e da gruppi organizzati che “filtrano e interpretano alla luce del proprio sistema di credenze le informazioni politiche e i messaggi dei leader”. Tra i gruppi organizzati spiccano i partiti politici, per i quali, nella normale dialettica democratica, l’informazione gioca un ruolo di primo piano. Tuttavia, non è detto che, tra coloro che si riconoscono nelle loro rispettive posizioni, i gruppi più informati “siano anche quelli capaci di giudicare eventi, situazioni e contesto in modo più realistico rispetto ai meno informati.” Infatti, in genere, “i cosiddetti ‘più informati’ sono anche i più ideologizzati”, tanto da poter far sorgere il sospetto che in molti casi sotto l’elogio pubblico di un’informazione rigorosa si celi il desiderio di fornire un alibi perfetto a un’incessante attività d’ideologizzazione.
Alla luce di questo quadro generale, possiamo tornare allora a chiederci cosa tiene uniti e coesi i gruppi che si riconoscono nelle posizioni dei partiti, partendo dalla constatazione che oggi non ci sono più partiti di massa, almeno nella forma in cui li avevamo conosciuti ancora nella seconda metà del Novecento: i partiti hanno ormai mutato pelle e hanno perso gran parte del loro radicamento sociale. La loro influenza sulla comunicazione si è indebolita e con essa anche “la capacità di controllare i processi di socializzazione politica”, come attesta anche, almeno in Italia, il sempre più consistente fenomeno dell’astensionismo. Negli ultimi anni i cosiddetti influencer hanno infatti assunto un ruolo sempre più rilevante, destrutturando il sistema dell’informazione che una volta garantiva l’allineamento a stabili identità politiche.
In questo contesto, anche l’identificazione degli elettori con i partiti passa sempre più spesso attraverso l’individuazione di gruppi “nemici”. Infatti, anche quando i partiti rimangono, rispettando correttamente il loro ruolo istituzionale, tra loro dei semplici “avversari”, i gruppi di elettori che tendono a identificarsi con le loro posizioni si percepiscono sempre più spesso come veri e propri “nemici”, che in quanto tali tendono a sottrarsi a quel confronto dialogico e razionale che costituisce un tratto saliente di ogni comunità democratica.
Questa situazione è particolarmente evidente quando movimenti di protesta sanno generare un’identità politica collettiva. In questo caso, i leader carismatici (in senso weberiano) che costituiscono i riferimenti di tali gruppi devono non solo saper minacciare le istituzioni avversarie che vogliono attaccare, ma suscitare anche la loro ostilità e la loro reazione: “carisma del leader e reazione negativa dell’istituzione-target alimentano la tensione e creano le condizioni per un forte investimento emotivo dei singoli partecipanti nelle sorti del movimento”. E tuttavia, nonostante la loro carica anti-istituzionale, i movimenti collettivi si trovano prima o poi di fronte a una scelta ineludibile: “o si trasformano essi stessi in istituzioni (è la ‘routinizzazione del carisma’ di cui parla Weber) oppure sono destinati a estinguersi. E con essi si estingueranno le identità politiche suscitate dai movimenti collettivi”.
In una situazione simile, secondo Panebianco anche “il confine tra arene civili e arene militari può facilmente venire meno. Ad esempio, anche la democrazia consolidata – un regime politico basato sulla competizione pacifica fra élite – può trovarsi a fare i conti con la violenza politica: un movimento armato secessionista, una sfida terrorista. Il terrorismo che colpisce la democrazia può essere di origine endogena, può avere radici prevalentemente interne (Italia e Germania negli anni Settanta del secolo scorso) oppure può trattarsi di un terrorismo di carattere ‘transnazionale’ (gli attentati jihadisti negli Stati Uniti, in Francia, Germania e altri paesi europeo nel XXI secolo). Ciò che scatta immediatamente è un sentimento di paura, e anche di panico, che si diffonde e che, nella democrazia, genera un dilemma: a quante libertà devono rinunciare i cittadini perché possano ricostituirsi condizioni di sicurezza?”
Questa domanda, che circola da anni nelle arene civili e alla quale vengono fornite risposte anche molto diverse, ma comunque tendenzialmente polarizzate, si rivela cruciale, perché dalla risposta che le si fornisce possono scaturire conseguenze opposte. In un caso si è disposti a rinunciare a una parte delle proprie libertà civili e politiche, e nell’altra a una parte della propria sicurezza, ma in ogni caso gli esiti non possono essere considerati sicuri: per esempio, di fronte a una minaccia terroristica, se i cittadini accettano il varo di leggi emergenziali che sospendono alcune garanzie individuali ci possono essere due tipi di conseguenze: la democrazia può sconfiggere i terroristi, oppure può non riuscirci, e in questo caso “è la stessa democrazia a rischiare di essere travolta”.
Le sfide alla sicurezza possono infatti, secondo Panebianco, “favorire crolli di regime”, perché possono provocare quell’anomia che contribuisce a sua volta a far crollare il consenso a un governo. In questo modo le istituzioni perdono forza, mentre cresce il bisogno di protezione e i cittadini si indirizzano verso quei gruppi che sembrano poterne garantire una migliore. In fasi come queste le norme istituzionali perdono efficacia e le stesse istituzioni sembrano ridursi a un’etichetta simbolica che viene utilizzata solo per la sua capacità di contrastare le fazioni rivali.
Quando poi la paura si spinge fino a far temere per la propria incolumità fisica, come accade nelle guerre civili, i cittadini sono portati a schierarsi ancora più marcatamente da una parte o dall’altra nella speranza di ottenere una qualche protezione, finendo così con l’alimentare gli opposti schieramenti. In queste fasi, i personaggi più carismatici riescono spesso ad assumerne il comando. La diffusa intolleranza e il clima di paura finiscono così spesso col favorire l’emergere di leadership autoritarie, mentre la violenza aumenta man mano che aumenta la radicalizzazione.
Angelo Panebianco, Identità e istituzioni. L’individuo, il gruppo, la politica, Il Mulino, Bologna 2025.